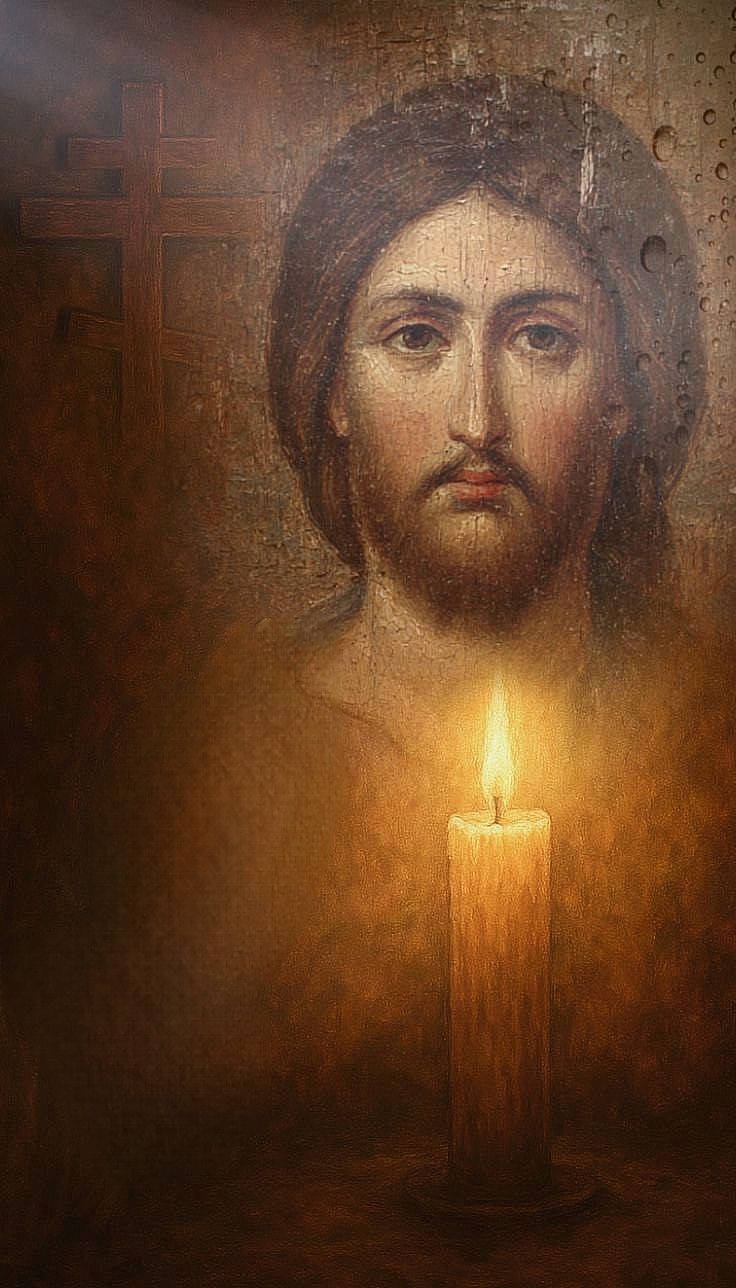Umile e alta più che creatura
Riflessioni mariologiche alla luce del canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri
Premessa
Molti si sono accinti in settecento anni di storia all'approfondimento di quel testo che risplende dell'ambito della letteratura italiana, la Commedia o Divina Commedia del poeta fiorentino Dante Alighieri. Molteplici sono stati gli approcci e i metodi ermeneutici: dalla critica letteraria in senso stretto, alla storicità celata nei canti, alla semeiotica e linguistica, e, non per ultima, la teologia. Il testo infatti, pur non avendo una precipua finalità teologica ne possiede un ventaglio contenutistico non indifferente. Tutta l'opera è impregnata di dottrina cattolica, enunciata in forma poetica, senza tradire in alcun modo la struttura portante della dogmatica del tempo ma veicolandola in versi, canti e allegorie che rapiscono in modo immediato il lettore.
È questa la chiave di ricerca e il fulcro contenutistico del seguente articolo: far emergere, in breve, alcuni punti nodali della teologia ascetica, mistica e sistematica medievale che soggiace al pensiero dantesco per poi giungere a descrivere la mariologia del Sommo poeta, là dove possibile, con spunti di attualizzazione che favoriscano una comprensione scientifica più ampia, un ausilio, al fine di corroborare la spiritualità personale ed ecclesiale, guardando a Colei che nei prefazi liturgici è definita segno di consolazione e di sicura speranza.
La Madonna è un elemento vitale della creazione dantesca.
Tutto il viaggio dalla selva del peccato, in cui il poeta si è smarrito, fino alla visione del mistero di Dio, ha come un filo nascosto, un'aurea catena che collega la vicenda umana e quella cristiana: è l'intercessione della Vergine Maria che suscita la misericordia del Signore e salva Dante dalla perdizione e lo porta alla salvezza, in un cammino che è utile anche per ognuno di noi. C'è un incipit nell'inferno, quasi un prologo, che darà avvio a tutto il viaggio: Dante è sull'orlo del baratro della dannazione; la sua vita sembra perduta in modo definitivo fino al momento in cui la Provvidenza viene in suo aiuto. La Donna lassù nel cielo) spezza il giusto ma severo giudizio di Dio. Il poeta dunque non è solo in questo tortuoso e arduo andare; esiste un disegno economico di Dio per mezzo della Vergine Maria.
Tre donne benedette
Curan di te ne la corte del cielo (Inf.II,124-125)
La Madre di Dio è la benedetta tra tutte le donne della terra che dal cielo volge i suoi occhi misericordiosi sulla terra, vede questo suo figlio nel pericolo e interviene. Poi chiama Lucia, santa siracusana a cui Dante è molto legato, e Lucia va da Beatrice, donna piena di virtù per guidare il passo. La Vergine Maria è la più perfetta tra le creature: perfetta nel cuore, nell'anima, nel corpo: la luce della Santissima Trinità, che presiede l'Empireo del Paradiso la inonda tutta. Il suo fulgore non ha pari tra i beati. Il suo grado di luminosità è altissimo e incomparabile. Perfetta perché bella, splendente, radiosa, collocata al centro del collegio dei santi nella Candida Rosa. Bella e perfetta perché umile, casta, pura e ricca di ogni virtù Lei chè Madre del Verbo incarnato. Per sua intercessione, preghiera e mediazione il sommo poeta può giungere alla visione e contemplazione della luce purissima per essenza: Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, meta del suo pellegrinaggio; appagamento di ogni sete e fame di Dio; ragione e senso ultimo del suo viaggio.
Secondo la Prof.ssa Beatrice Gelmi la Divina Commedia, non è dedicata, come molti ritengono, alla figura femminile di Beatrice, pur avendo questa un ruolo notevole nella vita e nella poesia dantesca, ma alla Vergine Maria. Non vogliamo entrare nel merito di questioni critico - letterarie ma di certo la figura di Maria è fondamentale nell'opera. Riporto qui di seguito la citazione in versione integrale:
La Divina Commedia, non è dedicata, come molti ritengono, alla figura femminile di Beatrice, che pure ha un ruolo notevole nella vita e nella poesia di Dante, ma a un'altra donna, al cui prezioso "Si" è legato il mistero dell'Incarnazione di Gesù e quindi la realizzazione del piano di salvezza dell'umanità. La centralità di Maria nell'opera dantesca ha un ruolo quindi fondamentale, che va al di là della semplice devozione (per altro molto sentita in tutti i tempi e anche nel Medioevo), essendo tema che corre lungo tutta l'opera e ne giustifica addirittura la nascita (1). È Maria infatti, la Grazia preveniente, la cui "benignità non pur soccorre/ a chi domanda, ma molte fiate/liberamente al dimandar precorre." (Paradiso XXXlIII,16-18), che si accorge dello smarrimento di Dante nella selva del peccato; è lei la "Donna [...] gentil nel ciel che si compiange", che ha misericordia di Dante riuscendo, con la sua compassione materna, ad attenuare addirittura la giustizia divina: "si che duro giudicio la sù frange," espressione che forse riecheggia Proverbi 25, 15 "et lingua molli confringet duritiam".[1]
Lo apprendiamo nel canto II dell'Inferno quando Dante è improvvisamente assalito dal dubbio che il viaggio nell'aldilà (l'altro viaggio) sia una folle prevaricazione (come il viaggio di Ulisse) e Virgilio, per dimostrargli invece che è un dono dal cielo, gli racconta di essere stato visitato nel Limbo da Beatrice, (mandata da Lucia, a sua volta chiamata da Maria) che l'ha supplicato piangendo di soccorrere l'amico [suo] e non della ventura.
È ovvio che se volessimo presentare la Vergine Maria tenendo conto di tutta l'opera dantesca non basterebbe un trattato. Il seguente lavoro, dunque, mira a una riflessione mariologica alla luce del più imponente scritto-preghiera del poeta incastonato nel XXXIII Canto del Paradiso.
A partire da lì affronteremo alcune questioni di ordine teologico.
· La via penitenziale o repressiva: l'inferno
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l'etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente
[...] Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate!
(Inf. 1-3; 9)
L'iter dantesco nella Divina Commedia si colloca come un sentiero ascensionale. Un cammino che parte dal baratro più profondo dopo lo smarrimento e lo sconvolgimento per risalire la china in modo progressivo e lento operando i più dettagliati e minuziosi passaggi attraverso i "luoghi" escatologici: l'inferno, il purgatorio e il paradiso al fine di contemplare il volto di Dio in Cristo suo Figlio e bearsi della sua luce. Dante si pone come il viator che cerca il riscatto, la vita e la luce perdute attraverso un cammino allegorico penitenziale, simbolo di tutta quella parte di umanità che dopo aver toccato il fondo della selva oscura si rimette in viaggio verso la libertà e la verità. È una vera e propria metànoia dagli anfratti oscuri e caliginosi dell'inferno allo splendore che regna sovrano nel cielo in modo tutto speciale nella Beata Vergine Maria e nella Santissima Trinità. L'uomo anela alla più perfetta unione con il suo Dio. Dobbiamo precisare però che tale cammino per Dante sarebbe stato fatale, se la grazia non gli avesse donato un'ancora salda che è l'amore. Sarà infatti questa la grazia particolare che lo guiderà attraverso il terrore del male nell'inferno.[2] Giunto a metà della vita, Dante si trova smarrito in una selva fitta e insidiosa: è la selva del peccato, dove è caduto perché si è allontanato dalla via del bene. Narrare questa drammatica esperienza costerà dolore e fatica, ma il poeta si accinge a farlo per mostrare il prodigio della Grazia e della Provvidenza sempre premurosa verso di lui come verso ogni uomo. Giunto ai bordi della selva, e vedendo un colle illuminato dai raggi del sole, Dante riacquista la speranza, dopo una notte di lotta con le tenebre del peccato, come un naufrago che intravede la proda e torna a credere nella salvezza.[3] La selva è oscura perché priva della luce della ragione e della illuminazione della Grazia; e dice oscuraper l'ignoranza e il peccato, che accecano e oscurano e richiedono le tenebre, poiché chi compie il male odia la luce. Tema caro all'evangelista Giovanni che ci ricorda nel Testo Sacro:
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.[4]
Ogni cantica costituisce una tappa di questo iter penitenziale verso una totale liberazione dal male e suoi vincoli (vizi). L'inferno segna l'inizio di tale percorso segnato dal tema oscuro e doloroso del peccato e di quanti hanno rinnegato la luce di Dio in questa vita. Vi è quindi una rappresentazione simbolica molto forte e inquietante del male e delle sue nefaste conseguenze, ove vige la legge del contrappasso, l'assenza totale della dignità delle persone descritte nella loro nudità, la presenza dei carnefici demoniaci, ma soprattutto segnato dalla mancanza globale di luce. Il tutto avviene in uno scenario drammatico e oscuro.[5] Dante compartecipa moralmente alla pena dei dannati turbandosi angosciosamente per la loro sorte creando in lui una presa di coscienza forte del peccato punito. Dinanzi ai macabri scenari di dannazione Dante ne resta sopraffatto.[6]
· La via illuminativa o esercizio delle virtù: il Purgatorio
Per correr miglior acqua alza le vele
ormai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;
e canterò di quel secondo regno
dove l'humano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.
(Purg. Canto I, 3-6)
Dante riemerge dall'inferno per affrontare la faticosa salita del Purgatorio rappresentata secondo la cosmologia del tempo, come un monte il quale protende verso l'alto: il Paradiso. Il suo viaggio, quindi si colloca in uno stato ascensionale. Il primo impatto del poeta con la nuova dimensione è quello di serenità e sollievo a tutti i livelli e la prima attrattiva metaforica è rappresentata dalla presenza delle stelle. Torna, dunque il tema della luce, che si era smarrito nella selva oscura e nei gironi infernali. La materia stessa del Purgatorio, riproduce un altro mondo, profondamente differente da quello infernale. Il poeta ha definitivamente abbandonato il regno della dannazione eterna con ogni sentimento che lo ha accompagnato. L'orizzonte si apre ora alla speranza attraverso il senso di sospensione, attesa, attrattiva, bellezza aurorale che mite si diffonde ad intra e ad extra dell'anima di Dante.[7] Esso è un regno transitorio non definitivo ed è strettamente legato al Paradiso a differenza dell'Inferno che ne è distaccato. Purgatorio e Paradiso sono intercomunicanti.[8] Ovviamente tale interconnessione è da intendersi ascensionale cioè dallo stato purgativo si sale allo stato celeste e non viceversa. Esso è stato creato per la purificazione si concluderà alla fine dei tempi con il Giudizio universale.[9] I temi ermeneutici fondamentali che emergono dal testo sono essenzialmente cinque: Amicizia, Coralità, Pellegrinaggio, Politica e Luce. Gli abitanti del Purgatorio sono tutti coloro i quali in vita hanno peccato ma comunque si sono pentiti ecco perché sono tenuti a fare il viaggio del monte fino alla perfetta purificazione. Da un lato soffrono, dall'altro hanno la coscienza umile di emendarsi definitivamente e la certa speranza dell'ingresso nel Paradiso. Anche in questo humus, sofferto sì, ma dagli orizzonti densi di pace e speranza si accenna alla figura della Madre di Dio che ci consentono di intravedere uno spaccato della cultura del tempo che ha precise rispondenze con la Vergine:
State contenti, umana gente, al quia;
ché se potuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria.
(Purg., Canto III, vv. 37-39)
È un invito da parte di Virgilio a non avere la pretesa di comprendere tutti i disegni e le azioni di Dio, in quanto se la ragione ne possedesse le capacità non ci sarebbe stato bisogno del mistero dell'Incarnazione. Vi è un'assoluta sproporzione tra le facoltà intellegibili e sensoriali dell'uomo e l'infinita trascendenza di Dio la quale è sempre al di là delle umane capacità. Già San Tommaso d'Aquino che è dietro l'attività poetica di Dante aveva indicato due strade per il raggiungimento della conoscenza di Dio: per via naturale, partendo dalle realtà create per giungere a quelle increate (le cinque vie), oppure affidarsi alla Rivelazione. Tuttavia Tommaso nella Summa Theologica asseriva che la Rivelazione è la via più conveniente in quanto la ragione o via razionale non è esente da errori. In questo contesto vengono innestati i versi succitati i quali parafrasati vogliono affermare questa semplice e universale verità: accontentatevi uomini delle cose che esistono altrimenti non ci sarebbe stato bisogno che Maria avesse partorito. La Vergine Santissima viene qui mostrata come la vera Sedes Sapientiae: la sapienza incarnata che è la seconda Persona della Santissima Trinità che reca in ginocchio come Bambino mentre Ella è sul trono regale.[10]
· La via unitiva o contemplazione della Divinità: il Paradiso
Nel ciel che più de la sua luce prende fu' io, e vidi cose che ridire
né sa né può chi di là su discende.
(Par. I, 4-6)
Completata l'opera di purificazione o penitenziale ecco che il sommo poeta sale verso il Paradiso sostenuto dalla guida di Beatrice. Anch'esso un viaggio che potremmo definire una navigazione o un librarsi di cielo in cielo e di luce in luce fino a giungere alla somma luce per l'ausilio e l'intercessione della vergine Maria. La struttura della dimensione paradisiaca obbedisce ai canoni cosmologici di natura aristotelico-tolemaica. Al centro vi è la terra la cui atmosfera è delimitata da una sfera di fuoco, intorno cui ruotano i primi sette cieli sui quali Dante incontrerà le anime dei beati pur avendo esse sede nell'Empireo. A seguire abbiamo l'ottavo cielo detto anche delle stelle fisse dove il poeta assisterà al trionfo di Cristo e della Vergine Maria. La sfera più estesa è quella del nono cielo, il Primo Mobile o cristallino, che dà movimento a tutti gli altri cieli. Qui vi sono i nove cori angelici che ruotano intorno ad un punto piccolo e luminoso che è Dio. All'esterno di questi nove cieli il poeta pone un decimo cielo eterno, infinito contrassegnato da un amore purissimo e da una luce radiosa. È l'Empireo, luogo in cui ha sede Dio nella sua essenza. Questa rappresenta la meta del suo peregrinare costituita dalla Candida Rosa dove abitano tutti i beati con i loro rispettivi seggi con al centro un lago di luce della Grazia di Dio.[11]
Il tema della luce è uno dei più predominanti. Il Paradiso è tutto plasmato di luce e di colore. Le allegorie sono molteplici.[12] Possiamo definire la terza cantica come interamente intessuta di ogni gloria, splendore e bellezza in cui risalta grandemente il dogma cristiano. Il Paradiso è il luogo dove tutto finisce o si consuma e dove tutto trova un senso compiuto e definitivo.[13] Esso è anche il luogo della perfezione dove i beati agognano la ricostituzione sostanziale con il proprio corpo glorificato dopo il Giudizio universale. Ma il Paradiso è anche il luogo della teologia non definita ovviamente secondo i canoni dogmatici. Essa è la scienza e lo strumento che conduce all'anima, contemplatrice del vero, delle beatitudini e della pace che non desidera altro di ascendere e consumarsi nella visione. Il Paradiso è altresì il compimento del desiderio innato nell'uomo che cerca, brama, ha sete di Dio. Nella visione-contemplazione esso raggiunge il culmine, il fine, il senso pieno. Ovviamente la visione non può essere frutto solo di sforzi umani o di capacità terreni, vi si giunge per grazia di Dio.[14]
· "Ha guardato all'umiltà della sua serva" Lc 1, 46-56
L'umiltà di Maria
Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'etterno consiglio,
tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore,
per lo cui caldo ne l'etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui sei a noi meridiana face,
di caritate e giuso intra i mortali
sei di speranza fontana vivace.
Donna, sei tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disianza vuol volar senz´ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi dimanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietade,
in te magnificenza, in te s´aduna,
quantunque in creatura è di bontade.
(Par. Canto XXXIII, 1, 1-21)
In questo testo succitato Dante giunge quasi al termine del suo lungo, faticoso e arduo viaggio. Ormai la sua anima pienamente purificata è pronta alla contemplazione di Dio nella sua più pura essenza. Essa è tuttavia preceduta da un'altra visione: quella della famosa Candida Rosa. Come ausilio trova San Bernardo di Chiaravalle fondatore dell'Ordine Cistercense, teologo, biblista e mistico, definito anche il cantore di Maria per il suo devoto affetto all'umanità di Gesù e alla Vergine Madre. Proprio Lui è il conducente, il maestro e l'interprete autorevole dell'estasi che ora Dante contempla. Il Sommo Poeta pone sulle labbra di Bernardola rinomata preghiera alla Vergine Santissima che ha poi ispirato pensatori cristiani, credenti, teologi e maestri di spirito. Tale orazione è entrata fin anche nella Liturgia delle Ore.[15]In stile sommamente lirico e denso di affetti e profondità teologica, tale preghiera rappresenta un inno alla bellezza, alla santità, all'umiltà e regalità della Madre di Dio al tempo stesso venerata come Madre del Verbo incarnato. Alla contemplazione del mistero di Maria si aggiunge un'accorata preghiera di intercessione affinché Dante possa raggiungere l'eterna e somma Luce.[16] La mediazione di Maria risulta fondamentale. A noi tuttavia interessa accostare alcuni versi di tale preghiera con brani della Scrittura al fine di un ulteriore approfondimento sul mistero della Vergine Madre. Del resto la Commedia non è solo un'opera culturale, politica e sociale, ma è innanzitutto un poema di fede e di speranza che possiede come substrato contenutistico la Divina Rivelazione e la teologia del tempo:
Il primo accostamento a cui ci approcciamo in punta di piedi è con il Magnificat: il cantico di lode, di benedizione e di adorazione da parte della Vergine Maria all'Onnipotente e alla sua opera salvifica che si realizza in lei e per suo tramite all'umanità intera. "La preghiera alla Vergine (di Dante) è intimamente sentita dal poeta, che, consapevole della sua bassezza e dell'altezza della grande Regina, cerca di accostare il finito all'infinito. L'antiteticità della grandezza umile, esaltata nel Magnificat, è racchiusa nel primo verso."[17] La terminologia adottata da Dante non avrebbe alcun senso se fosse attribuita a una qualsiasi donna, ma si rivela significante e verace se la si ascrive alla Verine Maria la quale, in virtù della sua grande, profonda e atipica umiltà raggiunge le più alte vette dei cieli sedendo in essi quale regina. Maria conserva la sua singolarità nella sommità della creazione.[18] Ma andiamo al testo biblico che fa luce su quanto abbiamo appena scritto:
L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre». Lc1, 46-55
Il cantico di Maria ci rivela perché Ella è alta e umile più che creatura. In questi versi mossi Dallo Spirito Santo, contenutisticamente profetici e sapienziali, la Vergine Maria si inabissa nel mistero di Dio. Il Magnificat è sostanzialmente diviso in due parti: la prima concerne Maria stessa e la seconda universalizza l'esperienza di Maria e riflette sul comportamento di Dio con l'umanità.[19] Dal mistero di Dio vede se stessa, vede la storia del suo popolo, vede la storia dell'umanità intera. Tutto è dal mistero di Dio e tutto si compie per il suo mistero e nel suo mistero. Dio è per la Vergine Maria il Grande, il Sommo, l'Eccelso. MegalØnw, rendere grande, significa qui, come spesso nella lingua religiosa dei giudei, magnificare, lodare, celebrare. Riconoscere la grandezza di Dio, così com'è celebrata, non è quella di un denominatore che umilia i sudditi, ma quella di un salvatore che impegna la sua potenza per la salvezza dell'umanità.[20]
Nessuno è sopra di Lui né per gloria né per onnipotenza. Egli è il Dio che fa la storia allo stesso modo che ha fatto la creazione. Tutto è nelle sue mani, nella sua volontà, nel suo amore, nella sua giustizia, nella sua verità. Per questo Dio deve essere magnificato, esaltato, celebrato, osannato, cantato. Egli è tutto e da lui ogni cosa per grazia, per creazione, per rigenerazione, per santificazione, per elevazione, per amore, misericordia, pietà, compassione, giustizia.[21] Non è la Vergine Maria che fa grande il Signore. Egli è grande, è il Grande per se stesso e da se stesso. La Vergine Maria riconosce e proclama la grandezza di Dio, la loda e la esalta, la benedice e la celebra. Maria è donna veramente umile e a tal ragione alta più che creatura. La sua bassezza va intesa come tale svuotamento di sé per essere integralmente disponibile a Dio e ai suoi doni di grazia. Non conta su se stessa ma si affida interamente a Dio e al suo piano salvifico.[22] L'evangelista Luca vuole sottolineare la dignità della Vergine, la Madre del Messia la quale possiede un'intrinseca ampiezza universale. Per sempre Ella sarà ammirata e celebrata nel mondo. L'anima della Vergine Maria magnifica il Signore. Il suo spirito invece esulta in Dio, gioisce nel Signore, che è confessato "mio salvatore". La Vergine Maria si vede salvata da Dio. Redenta da Lui, giustificata, elevata. Non per immersione nelle acque del battesimo, come avviene per ogni credente, o per la fede nella parola di Dio, come per l'Antico Testamento. Ella è salvata da Dio per prevenzione dal peccato originale. Ella fu preservata, fu piena di grazia, è resa giusta e santa in previsione dei meriti di Gesù. È Dio che l'ha fatta e voluta cosi. Dio per la Vergine Maria è vero salvatore. Per questa immensa grazia Ella esulta, gioisce, si rallegra nel suo Signore. Dinanzi al Signore e guardando in Lui l'anima vede sé stessa, la sua creaturalità, la totale dipendenza nell'essere e nell'agire. L'anima si vede guardata da Dio con uno sguardo di amore, di benevolenza, di divina carità. È uno sguardo che fa l'anima, le dona consistenza, bontà, santità, forza, volontà, ogni altra energia spirituale.
Nell'anima che vede Dio e che si conosce vista da lui nasce un inno di ringraziamento, di lode, di benedizione, di esultanza e di magnificenza. Dio è il tutto che tutto fa nell'anima se l'anima si lascia interamente fare da Dio. Maria è umile; il Signore l'ha vista nella sua umiltà; si è compiaciuta di Lei, l'ha amata per sempre, ne ha fatto l'oggetto del suo amore, di un amore assai singolare, unico nella storia dell'umanità. Maria è salvata per prevenzione. In questo sta tutta l'onnipotenza divina. L'anima di Maria lo sa e canta a Dio il suo ringraziamento.
La Vergine Maria è la sola creatura al mondo redenta e salvata per preservazione. Questa verità è tutta sua e di nessun altro. Dal primo istante del suo concepimento Ella è piena di grazia e sempre rimase piena di grazia crescendo di grazia in grazia. Nella Vergine Maria Dio compie ogni promessa precedentemente fatta. Dio non compie le sue promesse per un qualche merito dell'uomo. Le compie solo per misericordia, per amore, per bontà eterna ed infinita. Siamo redenti, salvati, giustificati, elevati dall'amore di Dio, solo per amore e dall'amore di Dio. Questo amore è stato promesso ad Abramo e a tutta la sua discendenza. Questo amore mai verrà meno per Israele, suo servo. Israele in qualsiasi momento della sua vita potrà sempre usufruire della misericordia di Dio. Questa mai le sarà tolta. La Vergine Maria è il frutto della grazia e della misericordia di Dio. Questa grazia e questa misericordia Dio le dona agli umili. Dio ha rivolto il suo sguardo alla bassezza (tapeinõsis) della serva. Con queste parole, Maria viene situata nel numero degli anawim, dei poveri di JHWH: sono le persone di poco conto, di umile condizione sociale, o disprezzate per qualche situazione penosa (malattia, sterilità); a queste persone che non hanno la possibilità di cambiare la loro condizione, Dio ha promesso di intervenire, di prendersene cura.[23]Anche Israele dovrà rivestirsi di umiltà e lasciarsi ricolmare dalla grazia e dalla misericordia di Dio. La Vergine Maria però non si situa fuori della promessa di Dio ad Abramo. È Lei la Donna attraverso la quale Dio dona inizio al compimento di ogni sua promessa. Lei è Figlia di Abramo e perché Figlia di Abramo Dio può compiere tutte le sue promesse. La Vergine Maria è anche Lei figlia della storia della Salvezza.
Questo canto, pur celebrando la grandezza di Dio, il suo braccio teso e la sua misericordia sulla storia dell'umanità che opera rovesciamenti inauditi e indicibili, è tuttavia anche un inno di gloria a Maria. Ella è glorificata, perché ha creduto in Dio permettendogli di compiere grandi cose per suo tramite. Per questo tutte le generazioni la chiameranno beata. Proprio in questo inno di lode troviamo il principio del culto cristiano alla Vergine Santissima e la certezza del suo valore e della sua sopravvivenza. Perciò come credenti, ancora oggi, fondandoci sulla historia ecclesiaecontinuiamo a cantare la grandezza di Maria, procurando di attualizzare il suo messaggio così come Luca ce lo ha presentato.[24] Maria vede tutta sé stessa in Dio; vede la gloria che le viene dalla sua divina maternità. Ella inscindibilmente è legata al mistero dell'Incarnazione; il mondo intero, nelle sue generazioni che si susseguiranno sulla faccia della terra, riconosceranno questa sua altissima dignità e la chiameranno beata.
Da quando Maria ha detto il suo sì alla Parola dell'Altissimo, da quel momento il mondo iniziò a chiamarla beata e prima fra tutte Elisabetta. È profezia questa che nessuna potenza diabolica, infernale, potrà mai oscurare, o porre sotto silenzio.
· "La vergine si chiamava Maria" Lc 1, 27
Verginità perpetua di Maria; la Θεοτόκος o Dei genetrix; l'immacolato concepimento
Facendo un passo indietro con la preghiera mariana del nostro poeta e precisamente al primo verso che recita Vergine Madre, figlia del tuo figlio, possiamo trarre tre grandi verità rivelate e successivamente postulate come dogma dalla tradizione vivente della Chiesa inerenti all'identità e alla natura della Vergine Maria. In primis la sua verginità perpetua. Tali versi, infatti, sono esplicativi, secondo gli studiosi, di una triplice coppia di attributi, di volta in volta antitetici e contraddittori secondo un criterio umano: ma tutti indistintamente veri da una prospettiva soprannaturale.[25]Tali opposti letterari facevano già parte di un modulo liturgico (Dei genitrix Virgo, genuisti qui te fecit).[26] Essi sono ossimori a cui è affidato l'arduo compito anche mettere in pian luce la verità dell'Incarnazione.[27]
Il quadro antitetico è il seguente:
- Vergine e madre;
- Figlia e madre di Dio
- La più umile e la più alta tra le creature.
Procediamo con ordine a partire dalla Sacra Rivelazione.
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele» che significa "Dio con noi". Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù. Mt 1, 18-25
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Lc 1, 26-38
Dio ha preparato un corpo per il Figlio suo. Corpo purissimo, castissimo, canto, senza imperfezione alcuna. Il Santo dei Santi doveva dimora in un'umanità santissima. Per questo dall'alto dei cieli il Signore volge lo sguardo a una vergine promessa sposa a Giuseppe della casa di Davide. Maria è vergine perché non conosce uomo. Ma non è solo una questione biologica o fisiologica; Maria è vergine anche nel cuore e nello spirito. Tutta per il suo Dio e Dio tutto per lei. Maria non ha fatto nulla da sé stessa. In Lei si sta compiendo un grande mistero. Ciò che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.
La profezia di Isaia riportata nel testo lucano usava il termine ebraico almàh (עלמה) con significato di fanciulla o di giovane donna in età di matrimonio ma non vergine. Gli evangelisti traducono la parola con il termine greco παρθένος (parthenos). Gli autori sacri voglio sottolineare che il concepimento di Gesù ebbe luogo informa miracolosa, dalla sola Madre vergine e cioè senza il concorso dell'uomo poi nulla è impossibile a Dio. Un evento straordinario, quindi, operato dalla potenza dello Spirito Santo.[28]Il termine vergine è usato propriamente per Maria per indicare il miracolo e il singolare intervento creativo di Dio nella nascita del Redentore.[29] In Maria si è compiuto un grande prodigio. È un prodigio inaudito, mai avvenuto nella storia antica, mai avverrà nella storia futura. Solo Lei ha concepito per opera dello Spirito Santo e nessuna altra donna al mondo. La Vergine Maria è rimasta sempre nella più pura e santa verginità. Ella è stata, è e sarà sempre di Dio. La verginità della Vergine Maria è nel dono pieno, totale, incontaminato, sempre santissimo, senza mai venire meno, al suo Signore. Il testo sacro ha voluto certamente parlare palesemente di questo mistero nel senso ovvio del termine e cioè di un concepimento avvenuto in Maria e tramite lei, sine virili semine.[30]
Il Signore le ha chiesto di essere tutta consacrata a Lui, perché attraverso di Lei Lui manifestasse tutta la sua gloria e Lei si è lasciata consacrare.
Lei è Vergine sopra ogni altra Vergine. Tutte le altre Vergini sono state del regno delle tenebre fino al giorno del loro battesimo. Maria mai è stata del regno delle tenebre. Lei non solo non ha conosciuto il peccato originale, in più dal Signore è stata colmata di grazia e di Spirito Santo.
Le altre Vergini sono state vergini nel corpo, hanno però dovuto liberarsi da ogni pensiero, desiderio, spesso anche da quei vizi sottilissimi che rallentano la consacrazione totale al Signore. Non sempre la verginità fisica è stata accompagnata da una totale verginità o libertà anche dai più piccoli peccati veniali. La Madre di Dio è Regina delle Vergini, Regina sopra tutte le altre Vergini, perché nessuna vergine è stata come Lei: purissima, santissima, immacolata. Lei mai ha conosciuto il peccato, neanche nel più picco moto inespresso del cuore. Lei è sempre, tutta del suo Dio in una crescita che è giunta al sommo della perfezione consentita ad una persona umana.
Come creatura, dopo la Vergine Maria, c'è solo la Vergine Maria. Dopo Maria c'è solo Cristo Gesù e la sua santissima umanità. Veramente il Signore per Lei ha fatto cose grandi. Fin dagli inizi la Chiesa ha accolto e professato questa verità. La perpetua verginità di Maria prende strada immediatamente nella coscienza ecclesiale. Più tardiva è l'espressione in partu ai tempi del Concilio di Efeso. La verità dogmatica viene però sancita definitivamente durante il Concilio Lateranense del 649 al 3° canone che si esprime così:
Se qualcuno non confessa, secondo l'insegnamento dei Padri, che Maria, Madre di Dio e santa e sempre vergine e immacolata, ha concepito negli ultimi tempi per opera dello Spirito Santo, senza seme virile, lo stesso Verbo di Dio, nella sua distinzione e in verità nato dal Padre prima di tutti i secoli e che lo ha messo al mondo, senza alcuna lesione corporea, restando vergine dopo il parto... sia anatema.[31]
Lei dal primo istante del suo concepimento e fino all'ultimo istante della sua permanenza sulla terra con il suo corpo di carne, è stata purissima Dimora, santissima casa del Signore nostro Dio. Non ha nulla a che vedere con le rappresentazioni mitologiche pagane nelle quali un dio, in sembianze umane, si unisce con una donna. Nel concepimento verginale di Gesù, Dio agisce con un atto simile alla creazione. Inoltre la Verginità di Maria manifesta la fede senza ombra di dubbio e la donazione piena della madre di Gesù alla volontà di Dio.
· Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. Mt 1, 23
La Θεοτόκος
Altra verità emergente da questi primi versi danteschi è il dogma della divina maternità della Vergine Maria. Ella è Madre, secondo i brani di Matteo e Luca, del Figlio dell'Altissimo, il quale possiede come titolo quello che Isaia aveva profetizzato: l'Emmanuele. Queste parole hanno una forte connotazione cristologica. Sono in primo luogo un riferimento all'Alleanza promessa da Dio con il suo popolo ma soprattutto il ricorso alla formula abbreviata Dio con noi ha un'eco nella storia di Israele che rimanda alla presenza e alla gloria di Dio (Presenza, Dimora, Tenda, Tempio) che si libra su individui o gruppi per mezzo di quella che i padri identificavano con שְׁכִינָה (shechinà). È la presenza tangibile, reale, vera di Dio in mezzo al suo popolo concepita come una luminosità brillante. Matteo in modo peculiare identifica tale presenza con una persona che è Cristo Gesù.[32] Collegabile con la pericope giovannea del prologo:
In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio...
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità...
Dio nessuno l'ha mai visto:
proprio il Figlio unigenito,
che è nel seno del Padre,
lui lo ha rivelato.
Gv 1, 1; 14; 18
Volendo parafrasare senza forzature il testo direbbe così: "E il Verbo si fece carne e pose la sua SHEKINAH (tenda) in mezzo a noi". In Cristo dimora corporalmente tutta la pienezza della divinità Col 2, 9 poiché egli è immagine del Dio invisibile Col 1, 15. La vergine Santissima, dunque, è per usare una paronomasia, una dimora della dimora. Tenda di Cristo il quale è per natura ed essenza abitazione visibile del Dio invisibile poiché Dio egli stesso. La Madre della she-chi-nà, del Dio-con-noi. Verginità e maternità divina di Maria sono un solo mistero rivelato. Ella è Madre di Gesù poiché nel suo grembo il Verbo si fece carne. Carne da carne nel seno di Maria, come nel seno del Padre è luce da luce, Dio vero da Dio vero. Il Lόγος è stato generato nella sua umanità, da Maria e dallo Spirito Santo. La divina maternità di Maria è mistero di cooperazione dell'uomo nell'economia salvifica. Dio opera con Maria, in Maria e per Maria non senza la sua libertà e piena responsabilità. Per nascere Dio ha necessitato di una Madre. È il mistero imperscrutabile di Dio che agisce come abbiamo avuto modo di approfondire precedentemente per opera del suo Spirito. Questi che è la terza Persona della Santissima Trinità, è la forza di Dio e la sua potenza che hanno adombrato tale umile e ad alta creatura così da rendere fecondo il suo grembo verginale. Eva è stata creata per essere di aiuto ad Adamo. È stata tratta dalla costola di Adamo. Adamo non è però padre di Eva. La Vergine Maria è impastata di grazia, verità, giustizia, verginità. Il suo è un fango purissimo e santissimo, senza alcuna imperfezione. Da Lei è stato tratto Cristo per generazione per opera dello Spirito Santo. Lei non è stata data a Cristo come sposa. Gli è stata data come Madre. Lei è vera Madre di Dio, perché Cristo Gesù è vero Figlio di Dio nella sua natura e Persona divina, natura e Persona che sono eterne. La differenza è abissale. Non ci sono paragoni possibili. Siamo in due mondi differenti. La partecipazione della divina natura in Maria è oltre l'umanamente immaginabile. Maria è il Capolavoro di Dio. La stupenda sua opera. Maria è lo Specchio nel quale il Signore può ammirare la sua onnipotenza, la sua misericordia, la sua grazia, la sua bontà, tutto di sé può contemplare in Lei. Maria appartiene a ciò che è il nuovo assoluto di Dio ed anche irripetibile. Nessun'altra donna potrà concepire per opera dello Spirito Santo ed essere Madre di Dio. Questo assoluto è eterno. È unico. È irripetibile. È solo di Maria.
Tu sé colei che l'umana natura
Nobilitasti sì, che 'l suo fattore
Non disdegnò di farsi sua fattura.
Dante per esprimere tale dogma, lo ripetiamo, ricorre ad un ossimoro: Vergine;Madre, figlia del tuo Figlio e per comprenderlo appiano dobbiamo indispensabilmente fare un riferimento al Concilio di Efeso del 431 d. C. lì dove andava chiarito, approfondito ed esplicato il significato teologico dell'espressione Θεοτόκος - Madre di Dio ampiamente usata dalle comunità cristiane del tempo. Tra l'altro c'è da precisare che tale espressione è testimoniata dai Padri precedenti il Concilio Efesino basti pensare a sant'Aristide, apologista della prima metà del II sec., sant'Alessandro Alessandrino, san Gregorio di Nissa e san Gregorio Nazianzeno, san Cirillo di Alessandria e San Nilo Abate, e si trova soprattutto in Atanasio; anche Sant'Efremcompone diverse Praecationes ad Deiparam.[33] Efeso si riunì per normare la divina maternità di Maria contro gli errori nestoriani i quali non concepivano nel Verbo incarnato l'unione di due nature: umana e divina. Anche se il problema non si poneva primariamente in ordine alla mariologia, benché di rimando, bensì alla cristologia. Molto sinteticamente diciamo che la quaestio si risolse in questi termini:
Noi quindi confessiamo che il nostro signore Gesù figlio unigenito di Dio, è perfetto Dio e perfetto uomo, (composto) di anima razionale e di corpo; generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, nato, per noi e per la nostra salvezza, alla fine dei tempi dalla vergine Maria secondo l'umanità; che è consostanziale al Padre secondo la divinità, e consostanziale a noi secondo l'umanità, essendo avvenuta l'unione delle due nature. Perciò noi confessiamo un solo Cristo, un solo Figlio, un solo Signore. A questo concetto di unione in confusa, noi confessiamo che la vergine santa è madre di Dio, essendosi il Verbo di Dio incarnato e fatto uomo, ed avendo unito a sé fin dallo stesso concepimento, il tempio assunto da essa.[34]
· "Ti saluto o piena di grazia, il Signore è con te." Lc 1, 28
Immaculata Virginis Conceptione
Altra verità emergente dall'orazione del Canto XXXIII seppur velata è l'Immacolato Concepimento della Vergine Maria il cui titolo di nobiltà designa il compiacimento del Creatore che non disdegnò il grembo della vergine[35]. Si potrebbe vedere adombrata una certa accoglienza da parte di Dante della "pia verità" dell'esenzione di Maria dal peccato originale.[36] Premettiamo che tale titolo pur essendo in auge presso il popolo cristiano e diverse scuole teologiche ai tempi del poeta, raggiunge la definizione dogmatica solo nel 1854 con la Bolla Innefabilis Deus di Papa Pio IX, che possiamo intuire dai versi:
Tu sé colei che l'umana natura
Nobilitasti sì, che 'l suo fattore
Non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si riaccese l'amore,
per lo cui caldo ne l'etterna pace
Così è germinato questo fiore.
Maria si è fatta tramite per la nascita di Cristo e ha reso così possibile la riconciliazione fra Dio e l'umanità dopo il peccato originale e ha consentito la salvezza universale a tutti gli uomini[37]. Tale mistero ineffabile è sempre contemplato in chiave cristologica e in particolar modo in vista dell'Incarnazione del Verbo di Dio nel grembo verginale e immacolato di Maria. Sappiamo bene che il movimento incarnazionale di Dio nel Figlio suo procede dall'amore stesso della Beata Trinità. È la dinamica d'amore di Dio uno e Trino ad estrinsecarsi da sé ed entrare nel mondo, nella storia degli uomini tramite il grembo di Maria.[38] Senza l'amore l'incarnazione risulterebbe incomprensibile. Amore donato e donante senza misura in vista della Redenzione. Essa è opera del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo; un processo agapico senza precedenti in Dio. Proprio a causa di tale amore quella fiamma soprannaturale di grazia che si era spenta e oscurata a causa del peccato d'origine, si riaccende e si ravviva nel seno della Madre di Dio. Frutto della Redenzione è la rosa raggiante dei beati.[39] Potremmo dire che la candida rosa è Maria stessa. Il fiore più bello, più profumato del Paradiso. La regina di tutte le rose che le vanno da corona nel seggio dei giusti. Da Lei è germinato il fiore dei fiori: Cristo Gesù. Tali immagini (il fiore e l'azione germinatrice) non sono un conio originale di Dante, ma provengono da un'antichissima tradizione letteraria profetica cf. Is 11, 1 e cf. Is. 45, 8 che lo stesso San Bernardo applicherà nella sua omiletica alla Vergine Maria.[40] Vi è una bellezza sul volto, nel cuore e nel corpo della Vergine Maria che attrae, seduce, rapisce. È la bellezza della sua creaturalità incontaminata e della sua volontà di obbedire alla volontà di Dio. Il Signore crea la Vergine Maria piena di grazia, la preserva, per un singolare privilegio in virtù dei meriti di Cristo a Lei applicati in previsione, da ogni macchia di peccato originale. La fa tutta bella, splendente, la rende più luminosa del sole. Dinanzi a tanta divina bellezza creata da Dio per la Vergine Maria, Dio se ne innamora. Se ne innamora così tanto che la elegge ad essere la Madre del Figlio suo. Anche se volesse, non potrebbe creare una donna così bella. In Lei il Signore Dio ha esaurito la sua onnipotenza. Non c'è un oltre di bellezza che lui possa pensare. Oltre la Vergine Maria vi è solo la bellezza eterna. Dio può creare altri diecimila miliardi di universi. Può fare i cieli nuovi e la terra nuova. Mai potrà fare un'altra Donna uguale alla Madre sua. Non può perché dovrebbe fare un altro séstesso. Ma Dio non può fare un altro Dio. Sarebbe un Dio fatto e non un Dio eterno. Ora ogni Dio fatto è solo una creatura. Veramente Maria è la bellezza divina creata. Maria è piena di grazia poiché, in vista dei meriti di Cristo Gesù, non ha mai conosciuto il peccato: sia originale che attuale. La grazia di Dio ha sovrabbondato totaliter. La Vergine Maria è Donna, anzi è la Donna per eccellenza, è la Nuova Donna creata da Dio e posta accanto all'Uomo, al Nuovo Uomo che nella sua Persona divina è insieme vero Uomo e vero Dio. Attraverso la Vergine Maria, Dio opera una nuova creazione. La Vergine Maria è stata fatta da Dio senza alcuna macchia di peccato originale. Noi nasciamo impuri, non perfetti, non pienamente veri. Nasciamo nel peccato, perché nel peccato veniamo concepiti. Noi portiamo nel nostro corpo, nella nostra anima, nel nostro spirito la pesante eredità di Adamo. Maria invece fu preservata per un particolare privilegio, in previsione dei meriti di Cristo. Ella è redenta per non contaminazione, per preservazione. Ma Dio ha fatto di Maria il suo Paradiso sulla nostra terra. In Lei Lui vuole abitare in eterno. Maria è stata il suo primo tempio santo sulla nostra terra. La sua casa. La sua abitazione per sempre. Maria è la Gerusalemme umana di Dio, il tempio umano del Signore, la sua casa in mezzo ai figli degli uomini. Per questo era ben giusto porre un vallo invalicabile a tutte le potenze del male affinché mai fosse superato. In Maria Dio ha potuto coltivare tutta la sua grandezza, bellezza, santità, misericordia, pietà. In Lei ha potuto raccogliere ogni frutto. Neanche un minuscolo insetto di male ha turbato questo giardino immacolato. solo questa la purezza della Madre di Gesù.
Dinanzi a tanto splendore e chiarore Dante già pregusta quella luce beatissima a cui aspira a giungere e che si trova solo nell'Empireo dove risiede Dio nella sua purissima essenza. A tal guisa il poeta si eleva in una supplica accorata e insistente alla Vergine Santissima, a cui accorre come avvocata e mediatrice, Madre amorevole e misericordiosa affinché preservi la sua anima dal peccato e faccia da scala verso l'ultimo traguardo del suo peregrinare.[41]
Conclusioni
Avremmo potuto scrivere pagine e pagine ancora sulla figura della Vergine Maria in Dante poiché la letteratura, la critica testuale, i contenuti, le ispirazioni sono davvero innumerevoli, di questa piccola Fanciulla di Nazaret adombrata dallo Spirito Santo di Dio e il cui grembo è divenuto tenda, casa, dimora dell'Alleanza fatta storia; ma quando ci si imbatte in un argomento di tale portata spirituale, teologica, storica, si ha sempre la sensazione di non aver scritto e sondato abbastanza, come di un lavoro sempre incompleto e in fieri, data la vastità dell'argomento e la molteplicità degli spunti di indagine che da esso muovono, proprio come affermava San Bernardo: «de Maria numquam satis».
Nella realizzazione e stesura del lavoro si è resa necessaria un'attenta selezione dei temi trattati, al fine di far emergere quelle verità universali ed eterne che mai alcuna cultura mondana potrà oscurare con il suo razionalismo ad oltranza e immanentismo cristiano che per certi versi, vorrebbe o eluderle o eclissarle, relegandole a categorie appartenenti al passato. Maria con tutto il suo essere, la sua verginità perpetua, la sua maternità divina e il suo immacolato concepimento non è mai fuori moda o fuori tempo. Ci sprona semmai, in un tempo in cui l'uomo si è fatto Dio, a crescere nella sua stessa umiltà che l'ha resa grande agli occhi dell'Onnipotente e agli occhi della storia e ha donato per mezzo suo il più bello tra i figli dell'uomo (cf. Sal. 44) nell'economia salvifica. Ci esorta ad essere altresì vergini nel cuore e nel corpo per appartenere solo a Cristo e non agli idoli del mondo. In virtù del battesimo, infatti, non solo abbiamo ricevuto in dono la salvezza e siamo stati resi figli nel Figlio per adozione, ma, ontologicamente, la nostra natura o, se vogliamo, il nostro DNA spirituale è mutato: ha assunto la forma di Cristo che vive e abita in noi come suo capolavoro da rendere perfetto e da modellare con l'aiuto della sua grazia sanante e santificante e con l'obbedienza perfetta della nostra fede alla sua parola. E ancora: Maria è divenuta Madre di Dio poiché Madre del Verbo incarnato ma allorquando tale processo ha raggiunto il suo apice sul legno della croce Cristo stesso nella persona del discepolo che egli amava ce l'ha consegnata come Madre nostra per sempre.
Tutti i titoli che Dante offre nella sua cantica a Maria non fanno altro che esprimere una semplice verità: senza Maria non si può attraversare la selva oscura della vita compiendo il cammino di purificazione e santificazione che ha come fine la realizzazione antropologica della nostra umanità fino al suo compimento nel regno di Dio, quando finalmente vedremo il suo volto.
Senza Maria non possiamo giungere a Cristo.
La Vergine Madre è l'archetipo, il paradigma delle nostre scelte feriali ispirate sempre al Vangelo e mosse dallo Spirito Santo ma anche la mediatrice di ogni grazia nell'unico Mediatore tra Dio e gli uomini per cui si pone, dal momento della sua Assunzione al cielo, quale Madre misericordiosa, tenera, attenta, vigile ai bisogni dei suoi figli e si pone nella Chiesa ̵ così come recita un prefazio liturgico ̵ quale segno di consolazione e di sicura speranza. L'opera del sommo poeta rappresenta indubbiamente un prezioso aiuto nell'arduo e straordinario percorso di comprensione di questo ineffabile mistero quale è Maria, ora sta noi lasciarci ispirare per riscoprire il ministero della Madre di Dio nella nostra vita: come singoli cristiani, come comunità ecclesiali, come ricercatori di teologia, muovendo sempre dalla certezza indissolubile del valore-chiave di Maria nel progetto di salvezza dell'umanità, certezza che farà così magistralmente cantare il sommo poeta:
Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz'ali.
Nicola De Luca
[1] B. Gelmi, Maria nella Divina Commedia, relazione tenuta in occasione della celebrazione patronale dell'Immacolata promossa dal Centro Culturale delle Grazie, 4 dicembre 2012, Società Dante Alighieri Bergamo.
[2] Cf. H. U. von Balthasar, Dante, Viaggio attraverso la lingua la storia il pensiero della Divina Commedia, Morcelliana, Brescia 1984, p. 51.
[3] D. Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, Sei, Torino 2017, p. 19.
[4]Gv 3, 19-21
[5]Ibidem 14.
[6] https://divinacommedia.weebly.com/introduzione-inferno.html.
[7] Cf. I. Biffi, Di luce in luce, Teologia e bellezza nel Paradiso di Dante, Jaca Book, Milano 2010, p. 47.
[8] L. M. Di Girolamo, Donna è gentil nel ciel..., 54.
[9]https://www.liceomedi.com/did_online/Dante%20e%20la%20sua%20teologia.PDF, p. 3.
[10] Cf. L. M. Di Girolamo, Donna è gentil nel ciel..., pp. 55-57.
[11] Cit., Dante, La Divina Commedia, p. 643.
[12] Al simbolismo allegorico è dedicata la ricerca dantesca di Charles Southward SINGLETON (1909-1985), volta ad accertare quegli elementi della struttura della Commedia che ne fanno un'imitazione del grande poema dell'universo creato e dei modi di scrittura di Dio (cfr. La poesia dellaDivina Commedia, trad. it., Bologna 1978, pp. 15-16). L'allievo del Singleton, John freccero, convinto che l'esegesi biblica fosse la forma scelta da Dante per esprimere la propria esperienza, arrivò a scrivere Dante. The Poetics of Conversion (Cambridge, Harvard University Press, 1986). Gli studiosi anglosassoni hanno sempre insistito sull'intenso operare della poesia di Dante sulla teologia. Si citano, ad esempio: R. Hollander, Allegory in Dante's "Commedia", Princeton, New Jersey, 1969; Dante Theologus-Poeta (1975), in «Dante Studies», 118 (2000), pp. 261-302; J. A. Scott, Understanding Dante, Notre Dame, Indiana, 1994, trad. it. Perché Dante?, Roma 2010, pp. 501-511; Z. G. Baranski, Dante e i segni. Saggi per una storia intellettuale di Dante Alighieri, Napoli 2000, il quale sottolinea la maggiore vicinanza del poeta alla tradizione simbolico-esegetica che a quella filosofico-razionale. Cf. https://www.danteolivi.com/dante-la-teologia/.
[13] Cit. I. Biffi, Di luce in luce, p. 47-48.
[14] Ibidem, 48-51.
[15] È l'Inno dell'Ufficio delle Letture del Comune della Beata Vergine Maria.
[16]Cf. Alighieri, La Divina Commedia, Il Paradiso, a cura di Natalino Sapegno, La Nuova Italia, Scandicci (FI) 1992, pp.391-392; 415.
[17] G. Palmenta, La Vergine Madre nella Divina Commedia, Edizioni Paoline, Catania 1971, p. 210.
[18]Ibidem.
[19] Nuovo grande commentario biblico, a cura di R. E. Brown, J. A. Fitmyer, R. E. Murphy, edizione italiana a cura di F. Dalla Vecchia, Giuseppe Segalla, Marco Vironda, Quesriniana, Brescia 2002, p. 888 n°22.
[20] F. Bovon, Vangelo diLuca 1, Edizione italiana a cura di o. Ianovitz, Volume I, Introduzione, Commento a I, I-9, 50, Paideia editrice, Brescia 2005, p. 106.
[21] Nuovo grande commentario, p. 888.
[22] G. Rossé, il Vangelo di Luca, commento esegetico e teologico, Città Nuova editrice, Roma 1992, p. 71
[23] Rossé, il Vangelo di Luca, p.71.
[24] Cf. Commento alla Bibbia Liturgica, a cura di E. Fornasari e G. Tomatis, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1986, p. 1127.
[25] Cf. Alighieri, La Divina Commedia, p. 416.
[26] Ibidem.
[27] B. Gelmi, Maria nella Divina Commedia.
[28] F. Ocáriz, L. F. M. Seco, J. Antonio Riestra, Il Mistero di Cristo, Apollinare Studi, Roma 2000, p.63.
[29] Piccolo Dizionario Biblico, di E. Obermayer, K. Speidel Klauss Voggt, G. Zieler, edizione italiana a cura di A. Minissale, edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1988, alla voce verginità, p. 336
[30] J. H. Nicolas, Sintesi dogmatica, Dalla Trinità alla Trinità, L'incarnazione del Verbo vol. I, Libreria Editrice vaticana, Città del vaticano 1991, p. 612.
[31] Nicolas, Sintesi dogmatica, p. 612.
[32] Cf. Nuovo grande commentario, p. 828 alla voce: nascita di Gesù.
[33] F. Rizzi, Il mistero di Maria Donna E Madonna, Riflessioni sulla Madre di Gesù attraverso Dante, San Tommaso e Maria Valtorta, edizioni Fede e Cultura, Verona 2013, p.59.
[34] H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Edizioni Dheoniane, Bologna 2018, alla voce Formula di unione n° 272, p.153.
[35] G. Palmenta, La Vergine Madre nella Divina Commedia, 211.
[36] Cf. L. M. Di Girolamo, Donna è gentil nel ciel..., p. 81.
[37] Alighieri, La Divina Commedia, p. 934.
[38] Cf. F. Ocáriz, L. F. M. Seco, J. A. Riestra, Il Mistero di Cristo, pp. 87-88.
[39] Palmenta, La Vergine Madre nella Divina Commedia, 211.
[40] Cf. Di Girolamo, Donna è gentil nel ciel..., p. 81.
[41] Cf. B. Gelmi, Maria nella Divina Commedia.