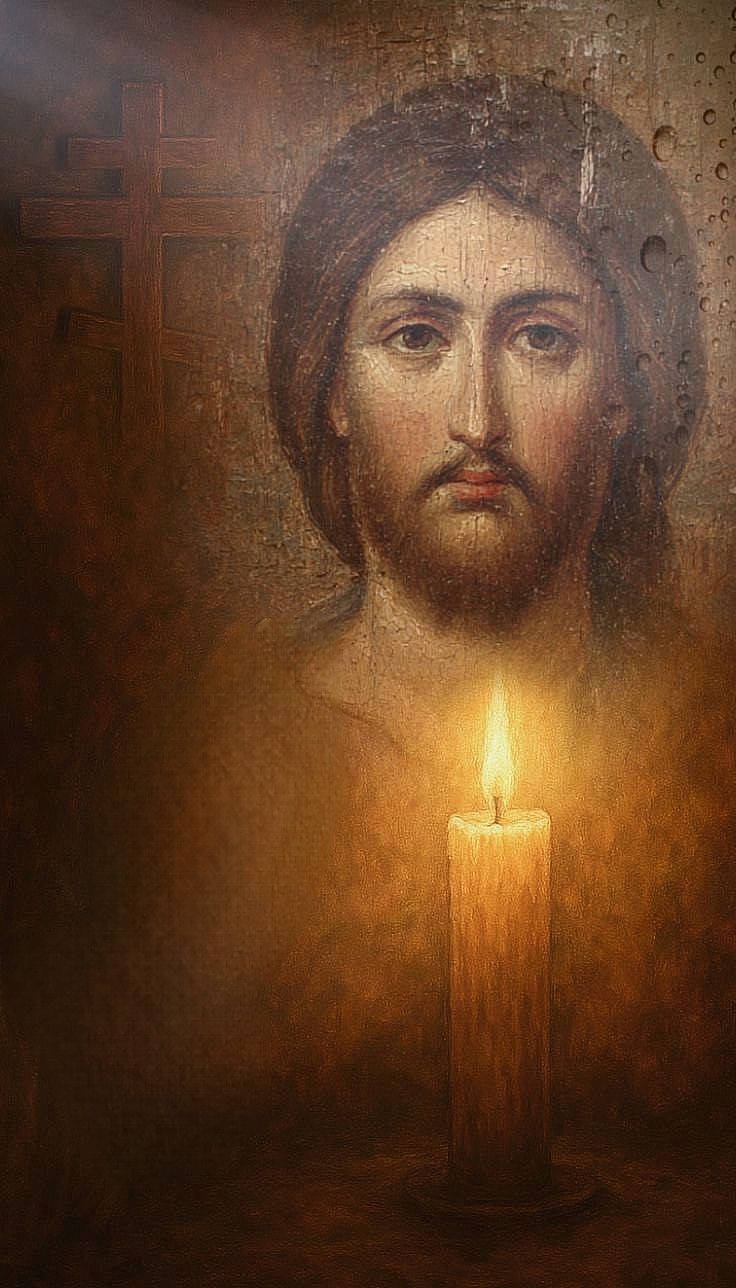La vera felicità
Seneca e Agostino maestri dell'oggi per un nuovo modello antropologico umano e cristiano

Ogni tipo di discorso sulla felicità, intesa essenzialmente come situazione di benessere dello spirito, non può prescindere da una lettura attenta dell'opera e del pensiero di Seneca e di S. Agostino. Intanto, ambedue gli autori la considerano come un bisogno intrinseco alla natura dell'uomo.
Tutti, infatti, tendono ad orientare l'impegno personale nelle prospettive del soddisfacimento dei propri desideri. La ricerca della felicità, quindi, aderisce ad una esigenza universale. Lo spazio di affinità tra Seneca ed Agostino, comunque sia, non si limita a tale considerazione antropologica. Si estende invece, ad ambiti più specifici dai quali emerge una stima di fondo comune: la felicità non è mai una condizione definita una tantum; non è un dato,ma un ritrovato; non è un punto di partenza,ma di arrivo. Essa, in altri termini, si identifica in un concetto limite.
Pervade la coscienza e, pertanto, implica una presenza di valore, che è la meta, la causa finale di un processo essenzialmente spirituale.
Come si vede, sia Seneca che Agostino evidenziano la costante della proiezione incommensurabile - pur nella finitezza dell'esistenza - verso l'Assoluto. Per loro, la felicità è una condizione in itinere, in cui la consapevolezza dei bisogni veri - e non fittizi - promuove insieme l'esigenza della felicità stessa e la coscienza della sua autenticità.
Il piacere che ne deriva è stabile, non caduco, temporaneo, subordinato. Seneca, tra l'altro, mostra la tendenza ad uscire dal panteismo classico, sotto la spinta di istanze spiritualistiche ispirate da un accentuato afflato religioso. Di conseguenza, la virtus è la capacità di essere al meglio, perché la Ragione non contraddice il sentimento del divino. Il suo Dio assume tratti perfino personali, che sono al di là dei canoni dell'ontologia stoica. In tal modo, egli scopre che la coscienza è una forza spirituale e morale fondamentale dell'uomo. La pone in primo piano come, prima di lui, nessuno - nell'ambito della filosofia greca e romana - aveva fatto. La coscienza determina la moralità dell'azione che, a sua volta, è presupposto di felicità.
Al contrario, come si è detto, anche la posizione di S. Agostino è eudemonistica, ma inquadra e risolve il problema della felicità in chiave cristiano-teologica. Il termine ultimo della ricerca, oltre ad essere un valore,è soprattutto Persona (Verbum Dei) o Persone Divine (Beata Trinitas). Mentre per Seneca la volontà - quindi la felicità - è determinata dalla ragione, per Agostino la verità umana è portata a confrontarsi con la Volontà divina, che porta alla scoperta dell'io come persona. Quest'ultima trova pace solo in Dio Uno e Trino; Uno nella natura Trino nella sostanza. La Verità, allora, abita in interiore hominis come parte integrante della vita spirituale e, al tempo stesso, la trascende, poiché fuori dell'uomo.
La felicità, di conseguenza, è possedere Dio, in un atto d'amore di Dio stesso attraverso la Grazia preveniente. La Provvidenza, dunque, permette all'uomo - che anela per sua stessa natura alla beatitudine - di scoprire in sé la Verità che spontaneamente dona la felicità. Quest'ultima, così, si identifica nella contemplazione del Sommo bene: «...beatitudo est gaudium de Veritate»[1].
Non è agevole, a questo punto, individuare i modi e la misura dell'influenza di Seneca e di Agostino sull'impostazione filosofica del problema della felicità, così come si è andato evolvendo nei periodi successivi. Soltanto in Cartesio e in Spinoza si possono cogliere, magari con un pò di ricercatezza, particolari rilievi sulla felicità, che è il compiacimento della conoscenza intuitiva di Dio. È certo, poi, che non vi è alcun carattere eudemonistico nell'atteggiamento speculativo contemporaneo. Kant, ad esempio, pur nel generale ed estremo rispetto per il Bene, scinde la felicità dalla morale, che è autonoma, non condizionata da secondi fini, qualsiasi sia la loro natura. Di qui il valore deontologico del "devi, dunque puoi".
Senza contare, poi, che le prospettive consumistiche dell'ambiente storico più vicino a noi hanno accentuato i risvolti e le conseguenze di teorie sempre più edonistiche. In generale, oggi la felicità è ricerca del piacere inteso come godimento sensibile. È tale, sia se riferito alla vita vegetativa, sia se riferito alla vita psichica. Una volta che la felicità è nel piacere, le differenze vanno individuate soltanto nel modo e nella qualità delle emozioni che lo determinano. Perfino il turbamento estetico, derivante dal Bello, converge verso prospettive che, quasi sempre, non sono quelle spirituali, quindi trascendentali.
In ogni modo, è indubbio che Seneca e S. Agostino restano due punti di riferimento decisivi per chiunque voglia addentrarsi in una lettura metafisica della felicità intesa come piano evolutivo, cioè come progetto e come metodo di vita.
Scriveva Giovanni Paolo II nel libro Varcare le soglie della speranza: «Per liberare l'uomo contemporaneo dalla paura di se stesso, del mondo, degli altri uomini, delle potenze terrene, dei sistemi oppressivi, per liberarlo da ogni sintomo di paura servile nei confronti di quella forza prevalente che il credente chiama Dio, occorre augurargli di tutto cuore di portare e coltivare nel suo cuore il vero timore di Dio, che è principio della sapienza. Questo è timore creativo, non distruttivo. Genera uomini che si lasciano guidare dalla responsabilità, dall'amore responsabile»[2].
Concetti come "timore di Dio quale principio della sapienza"o come "responsabilità e amore responsabile", richiamati da un pontefice dei nostri tempi, contribuiscono, senza dubbio, a confermare la congruenza tra la sollecitudine, oggi ineludibile, nei confronti della odierna condizione dell'uomo, che richiede urgenti e terapeutici rimedi, e la scelta di rivisitare il pensiero di Seneca e di Agostino per evidenziare i caratteri di attualità e di perennità delle loro indicazioni circa la via da percorrere.
Quando Seneca , nei primi paragrafi del suo De vita beata, sostiene che non bisogna affidarsi al parere della moltitudine per determinare la via da seguire per raggiungere la felicità e ribadisce come il solo strumento che, al di là delle apparenze, aiuti a distinguere il bene dal male sia l'animo, o quando, più avanti nel testo, raccomanda che la ratio sovrintenda ai sensi perché questi non si lascino trascinare dalla voluptas, e ancora quando di se stesso dice di tendere ad essere almeno il migliore dei malvagi , cominciando con l' "obiurgare meos errores" nell'incamminarsi verso la saggezza, indubbiamente ci invita a lasciarci guidare dalla responsabilità, cui si riferisce Giovanni Paolo II: e per Seneca la responsabilità è generata dalla Virtus che è propria dell' animus fortuita despiciens, virtute laetus, con il quale egli identifica il summum bonum.
Allo stesso modo, i concetti di modus (misura) e di temperantia (limite) su cui Agostino insiste nel trattare della egestas ( sinonimo di stoltezza) e della plenitudo ( sinonimo di saggezza), altro non sono che sinonimi del concetto di responsabilità.
Gli scritti di Seneca e di Agostino, e in particolare la vita beata e il De beata vita, confermano la "perennità" di filosofie che non ci riferiscono il già pensato, bensì ciò che perennemente richiede di essere ripensato.
L'uomo di oggi che, lungo strade spesso difficili e apparentemente senza sbocco, è, comunque, sempre alla ricerca di Dio è l'uomo di Agostino alla ricerca del "portum ", del vero senso, cioè, della sua esistenza o della "beatae vitae regionem".
L'uomo di oggi al servizio di esigenti padroni quali il successo, la ricchezza, il potere, incantato dalle effimere ma rutilanti promesse della "fortuna", alle prese con giochi, scommesse e quant'altro faccia intravvedere spropositati e gratuiti guadagni, è lo stesso uomo cui Seneca fa riferimento quando cita la Fortuna per dirci che essa non concede nulla in proprietà assoluta e ci ricorda la pratica, propria del saggio, della praemeditatio, la meditazione, cioè, ogni mattina prima di iniziare la giornata, su questa deludente, ma reale, caratteristica della Fortuna stessa.
Per quanto attiene, infine, alla felicità, quella autentica, che non dipende da cause esterne contingenti, Seneca ribadisce che il segreto è "resistere ai timori, alle paure, alle incertezze, è vincere i propri vizi per acquistare la virtus....., rimanere indifferenti ai doni della Fortuna".
E Agostino, sostenendo che l'infelicità non deriva tanto da ciò che non abbiamo, ma dalla paura di perdere i beni verso cui siamo inclini e che desideriamo, conclude, e ci sembra proprio che il suo interlocutore possa essere, e realmente sia, l'uomo dei nostri tempi, che "se qualcuno ha deciso di essere felice, si deve assicurare ciò che rimane per sempre e non può essere sottratto dalla spietata fortuna". E il suo messaggio, che non muta, l'unico che promette una verità difficilmente discutibile, è che "solo Dio è eterno e non cessa mai di essere".
Di S. Agostino, Giovanni Paolo II, nella Lettera Apostolica Augustinum Hipponensem scriveva: «A chi cerca la verità, egli insegna a non disperare di trovarla; insegna a cercarla con umiltà, disinteresse e diligenza; insegna a superare lo scetticismo attraverso il ritorno in se stesso, dove abita la verità; a superare il materialismo che impedisce alla mente di percepire la sua unione indissolubile con le realtà intellegibili; a superare il razionalismo che, ricusando la collaborazione con la fede, si mette nella condizione di non capire il "mistero" dell'uomo[3]». Tutto questo, diceva il Papa, Agostino lo dice agli uomini di oggi.
Per concludere, conferma la "perennità" di pensatori quali Seneca e S. Agostino quanto scrive F. Piemontese: «Vi sono verità ... pregnanti di vita, sovrabbondanti di intima ricchezza e immensamente feconde, le quali, pur ripresentandosi di volta in volta sotto un profilo nuovo, e come risposta a domande poste in condizioni nuove, e perciò nuove anch'esse, sovrastano per un altro verso, anche storicamente, l'articolarsi delle prospettive. Lo sovrastano, in quanto le varie prospettive, il molteplice avvicendarsi dei pensamenti umani e la stessa 'civiltà' che se ne alimenta, attingono indefinitamente ad esse, alla loro virtualità segreta che viene facendosi luce manifesta. La storia del pensiero continua ad attingere ad esse , perché, interiormente ricche come sono, sono sempre attuali, cioè hanno sempre una risposta per ogni nuovo problema»[4].
[1] Cfr. Conf., X, 22.
[2] Giovanni Paolo II, Varcare le soglie della Speranza, Mondadori, Milano 1994, p. 251.
[3] Giovanni Paolo II, Augustinum Hipponensem, Lettera Apostolica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel XVI centenario della conversione di Sant'Agostino Vescovo e Dottore della Chiesa, Libreria Leoniana, Roma 1986, p. 39.
[4] F. Piemontese, La verità agostiniana e l'agostinismo perenne, Marzolati, Milano 1963, pp.196-197.
Nicola De Luca